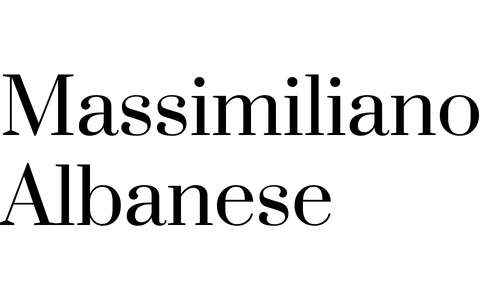In occasione della redazione di un mio recente contributo per la rivista Economy Magazine (visionabile da questo link), ho avuto modo di formulare alcune brevi riflessioni sul tema della crisi occupazionale e del salario minimo.
Me ne ha dato spunto l’approvazione, avvenuta lo scorso 19 ottobre 2022 a larghissima maggioranza in seno al Parlamento Europeo, della nuova direttiva sul salario minimo, divenuta cogente il 14 novembre dello stesso anno.
Un provvedimento quadro, per l’indirizzo delle politiche sulla materia nei vari Stati membri dell’Unione, che ha riacceso anche in Italia i riflettori sul tema delle garanzie per i lavoratori, proprio all’indomani delle ultime elezioni politiche del 25 settembre 2022, da cui sono derivati un’ampia maggioranza parlamentare ed un Governo di area centro-destra, in una fase storica di particolare difficoltà economica, in cui l’inflazione crescente ed il costante aumento dei prezzi dei beni di largo consumo impone l’adozione di efficaci strumenti di tutela del potere d’acquisto delle famiglie.
Un’esigenza il cui contraltare, tuttavia, rischia di essere l’appesantimento dei già rilevanti oneri a carico dei datori di lavoro, in uno scenario in cui sono prima di tutto le imprese – ed in special modo quelle di più piccole dimensioni – a subire le dirette conseguenze di una crisi multiforme, iniziata con la pandemia da covid19 e proseguita con l’instabilità geopolitica determinata dalla guerra tra Russia ed Ucraina e le sue conseguenze sui prezzi in tutti i settori merceologici.
Non v’è dubbio che la regolamentazione salariale sia da ritenersi garanzia di stabilità e coesione sociale, avendo il fine di consentire ai lavoratori una vita dignitosa, con il soddisfacimento dei loro bisogni primari (il c.d. “minimo biologico” costituito da abitazione e servizi di base, alimentazione e vestiario non di lusso) e la possibilità di accedere a qualcosa che, sebbene entro certi limiti, vada un po’ oltre la semplice sussistenza (il c.d. “living wage”).
La nostra Costituzione è chiara nello stabilire, all’art. 36, che il diritto dei lavoratori, ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, si attui proprio per mezzo di un compenso sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa per l’intera famiglia del lavoratore.
Nell’impianto costituzionale, i parametri della “proporzionalità” e “sufficienza” dovrebbero quindi consentire alla contrattazione sindacale la fissazione di un salario minimo universale: tuttavia, la mancata concreta attuazione dell’art. 39 della Carta, dedicato appunto all’ordinamento dei sindacati, ha reso incompleto il sistema, essendo i C.C.N.L. vincolanti per le sole parti che li sottoscrivono e, quindi, per i soli datori di lavoro e lavoratori iscritti alle rispettive associazioni di categoria che partecipano alla stipula.
Vi è dunque una larga sacca di rapporti di lavoro non coperti dalle garanzie dei C.C.N.L. e, per tentare di riempire questo vuoto di tutela, il c.d. Jobs Act, di cui alla legge 183 del 2014, aveva previsto una delega al Governo per l’introduzione di un salario minimo legale nei settori non coperti dalla contrattazione collettiva: anche tale delega, tuttavia, non è stata mai attuata.
Durante la XVIII Legislatura sono state avanzate delle proposte di legge volte a risolvere questo problema, con l’istituzione di un salario minimo universale, individuato nella retribuzione oraria minima di 9 euro, netti o lordi a seconda dei casi: il percorso parlamentare di tali proposte non si è però concluso prima dello scioglimento anticipato delle Camere, sicché le stesse sono decadute.
A sottolineare l’urgenza del tema, già dal giorno d’insediamento della nuova Legislatura, il 13 ottobre 2022, è stata presentata una nuova proposta di legge, in atto all’esame della Camera dei Deputati, in cui si prevede l’estensione dell’efficacia dei C.C.N.L. a tutti i lavoratori del settore d’interesse dei contratti stessi (quindi, indipendentemente dall’essere i datori di lavoro ed i lavoratori iscritti alle rispettive associazioni di categoria che quei contratti hanno stipulato), nonché l’adozione di un salario minimo, fissato annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quegli ambiti di attività che i C.C.N.L. non coprono.

Il dibattito politico sul tema rimane molto acceso, posto che l’evidente difficoltà, di pervenire all’effettiva attuazione di una regolamentazione del salario minimo, risiede nella circostanza che la stessa potrebbe determinare anche rilevanti conseguenze negative, sia in danno dei lavoratori che delle parti datoriali.
Da un lato, infatti, l’ulteriore aumento del costo del lavoro porterebbe certamente ad una riduzione dell’occupazione regolare, a fronte di un corrispettivo incremento del ricorso al lavoro nero.
Dall’altro lato, l’introduzione di un parametro legale di determinazione delle retribuzioni priverebbe di effettivo potere contrattuale le parti sociali e, non valorizzando le peculiarità dei C.C.N.L. (nei quali i minimi retributivi sono costituiti non solo dai c.d. “minimi tabellari” ma anche da componenti aggiuntive, quali ad esempio tredicesime e quattordicesime), potrebbe avere, in concreto, l’effetto paradossale di ridurre i salari rispetto a quelli oggi in essere.
In tale quadro, neanche l’intervento dell’Unione Europea appare risolutivo: l’art. 153 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) esclude, infatti, la possibilità di un regolamento direttamente applicabile in tema di retribuzioni, sicché da Bruxelles possono giungere agli Stati membri unicamente delle indicazioni di principio.
Così è stato con l’approvazione della nuova direttiva, che contiene appunto i principi ai quali i singoli Paesi dovrebbero attenersi nella valutazione dell’adeguatezza dei salari minimi da ciascuno di essi garantiti, tra i quali, la fissazione di un paniere di beni di consumo a prezzi reali cui parametrare le retribuzioni, oppure la determinazione in percentuale rispetto ai salari medi del mercato del lavoro interno.
Dovrebbe inoltre essere attuata una politica d’incentivo alla contrattazione collettiva, anche attraverso piani d’azione volti ad aumentare l’aggregazione sindacale dei lavoratori. E si dovrebbe infine istituire un sistema di monitoraggio affidabile, con controlli sul campo, per garantire la conformità dei singoli rapporti di lavoro e contrastare fenomeni elusivi, quali ad esempio il lavoro autonomo fittizio o gli straordinari non registrati.
Già prima della direttiva in discorso, 21 dei 27 Stati membri avevano adottato una regolamentazione interna sul salario minimo garantito: sono unicamente l’Italia, la Danimarca, l’Austria, la Finlandia, la Svezia e Cipro i 6 membri privi di tale normativa. Un dato sul quale è certamente opportuno riflettere.
Ma, nell’attuale contingenza economica e sociale, il vero tema del quale la politica dovrebbe prioritariamente occuparsi rimane, senza dubbio, quello della creazione delle condizioni per l’aumento dell’occupazione: garantire un salario minimo ad un numero ancora troppo limitato di lavoratori è infatti misura certamente insufficiente, da sola, a fronteggiare la profonda crisi economica in atto. Che, almeno in parte, è aggravata dalla crisi occupazionale endemica.
Non vuole essere questa la sede per approfondire il tema dei sostegni pubblici erogati a favore di chi non dispone di un lavoro, che tuttavia rimane strettamente collegato a quello del salario minimo e della creazione di opportunità d’impiego: non a caso, è ormai ampiamente condivisa dall’intero arco costituzionale l’esigenza di rivedere ed implementare le politiche attive del lavoro, allo scopo di rendere più funzionale e sostenibile il c.d. “reddito di cittadinanza”, di cui al decreto legge 4/2019 convertito dalla legge 26/2019 e da ultimo modificato con la legge 197/2022.
Si è trattato di una misura che, nella sua originaria configurazione, ha certamente alterato il mercato del lavoro nel nostro Paese, offrendo una vera e propria alternativa all’occupazione. A mio parere, tuttavia, il diritto al lavoro deve essere bilanciato da un dovere al lavoro stesso, che costituisce il fondamento della nostra Repubblica ai sensi dell’art. 1 della nostra Costituzione.
La riforma del sistema di politiche attive del lavoro e della formazione professionale, con lo scopo di migliorare le condizioni di occupabilità e le competenze dei lavoratori, sono tra gli obiettivi del PNRR, che finanzia con 6,6 miliardi le iniziative in questo settore. Ma, più in generale, tutte le riforme istituzionali, le opere infrastrutturali e, soprattutto, le c.d. “transizioni”, in special modo quella ecologica e quella digitale, possono rappresentare un volano per generare occupazione e migliorare le condizioni di vita e sociali delle famiglie italiane.
Dovrebbe essere assolutamente premiata, a mio avviso, soprattutto la capacità d’innovare, favorendo l’accesso ai fondi per quei progetti – siano essi pubblici o privati – che risultino idonei allo sviluppo occupazionale.
La piena tutela dei diritti dei lavoratori, dunque, potrebbe e dovrebbe essere attuata non solo e non tanto con l’introduzione di un salario minimo e/o con l’offerta di un reddito di tipo sociale alternativo a quello derivante dal lavoro, bensì con l’attuazione di scelte economiche, industriali, di politiche del lavoro e sociali volte, appunto, alla generazione delle condizioni per l’incremento dell’occupazione.